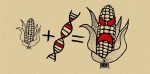IN APPROCCIO ALLE OMBRE
Testo e fotografie Laura M. Alemagna
Umaia è comunità agricola nei Colli Tortonesi dal 2021. Dall’atto di costituzione ha iniziato un rigoroso lavoro di messa in discussione del proprio nucleo e dei propri modi di produzione.
«Portate gli stivali». È il messaggio perentorio che arriva al mattino da Felicia, prima di partire.
Umaia è una destinazione desiderata da molto tempo. L’agguantiamo un soffio prima dell’Epifania. È un giorno umido, freddo, lattiginoso. Nel tortonese ha piovuto dopo giorni piuttosto asciutti. La terra è pregna d’acqua, l’argilla ha preso forma, è cresciuta. Molle, agguanta le suole, le scarpe, tutte, fin anche le caviglie. Bisogna attrezzarsi.


La strada per Cornigliasca, frazione di Carezzano, Alessandria, scorre parallela a un via vai di ciclisti, vista la giornata, neanche tanto fitto. Questa è stata zona di Fausto e Serse Coppi, ne scorgi i natali nei nomi delle cittadine, nei musei dedicati, nei monumenti a due ruote. In bicicletta è arrivata qui anche Felicia Carotenuto, molti anni fa, partendo dalle nostre parti alla volta delle Valli Unite. Un passaggio che segnò con curiosità la sua memoria e il cuore e dove tornerà dopo molto girare.
Cornigliasca, dove stanno, è un piccolo paese, piccolissimo. L’arrivo di Umaia, comunità agricola, ha innalzato l’esiguo numero di abitanti e abbassato l’età media, con la dolce prole che la abita.
Il paese era perlopiù disabitato, forse perché fuori, troppo lontano dai tempi moderni.
Per il territorio lo spopolamento è stato devastante, le già piccole frazioni si sono svuotate, di persone, di mestieri, di cura, di voci, di giochi per strada, di agricolture. Si è arrivati al punto zero intorno agli anni Novanta, quando per un lungo decennio non c’è stata neanche una nascita. Un’ecatombe sociale, culturale, cultuale.
L’arrivo di questo strano gruppo ha scompigliato le carte. Con il loro lavorare con metodo strano, a tratti obsoleto, i modi buffi, il via vai di ospiti, WWOOFer, amici, curiosi.
Tra le frazioni di Carezzano, Cornigliasca ha un’esposizione non troppo conveniente, tutta a nord, in ombra. Si faceva un tempo, ove necessario: “sacrificare” le case e lasciare alle terre da coltivare il conforto del sole.
In questo luogo, nel punto più estremo di questo nord, Umaia ha preso casa e terra.


Bisogna essere quantomeno un po’ matti per scegliere di lasciare una città, Milano, e darsi all’agricoltura, oggi. Bisogna esserlo molto, di più, se lo fai a Cornigliasca, in quell’approccio alle ombre. È solo il primo dei mille spericolati guizzi compiuti da questo piccolo nugolo di umanità: optare per la scelta più difficile e faticosa, scommettere sull’inaspettato, dare fiducia ai luoghi, alle persone, al tempo, al clima, anche se sembrano ostili. Affrontare sfide, osare nonostante le premesse, nonostante i pregiudizi.
Farlo in gruppo, come comunità, è l’altra impresa folle, è «la sfida più grande».
QUESTE COLLINE SONO UN ARCIPELAGO
Dalla parte opposta a Umaia, Felicia indica subito il luogo delle Valli Unite, a sud.
Oggi sono difficili da scorgere tra le nebbie; la vicinanza è però percepibile a fiuto e a orecchie. Vicine, non solo negli intenti, nelle pratiche, per gli scambi. Nell’apertura della voce c’è il suono di chi parla come di un’altra casa.
Proviamo a scorgere il sentiero che porta lì. È una linea tenue che vediamo insinuarsi verso valle e poi risalire entro i boschi.
Un’ecatombe sociale, culturale, cultuale, si diceva, ma se a un certo punto, in questo territorio, qualcosa è cambiato, se da un certo punto in poi ti sei trovato a sentire lingue mai sentite prima, se hai cominciato a incrociare volti diversi, stranieri, a sentire suoni nuovi, a vedere due cavalli, furgoni di effige fricchettona, dai la colpa a Valli Unite: la storia è cambiata, negli anni Settanta, con Ottavio Rube, Enrico Boveri e Cesare Berutti. Giovanissimi, fecero un rivoluzionario passo indietro di fronte ai cancelli della fabbrica e tornarono alla propria terra, di famiglia. Fu così che l’incolto ritornò a rifiorire.
Non è stato di sicuro facile ma, negli anni, insistendo, le cose sono via via cambiate.
Quella voglia di trasformare le cose, il proprio vissuto, ha avuto esito, ha germinato numerose altre storie, nuove, nate dalla spinta propulsiva vissuta alle Valli, nate dagli stimoli, dall’esempio, dal rifiuto, dagli scazzi anche.
Oggi questo territorio è ancora luogo di trasformazioni, c’è fermento. E Umaia ne è parte complice.
In questo arcipelago altre isole, altre costellazioni, che non sono poi così distanti. Pensiamo. La Morella di Enio Ferretti, Cascina Nerchi, La Campeggia, La Tana del Troll, Gabriele Patriarca, Daglio, Cascina Gentile. Altre valli che in linea d’aria sono attimi. «Certo, c’è sempre da svalicare», ma è una beata necessità, un’occasione per incontrarsi, per elaborare alleanze, discutere, mandarsi al diavolo, confrontarsi su questioni vitali, insieme.
Nel tempo di inforcare gli stivali, Felicia già scivola giù per valle, tra orti, luoghi di lavoro, campi e vigne di Umaia. La seguiamo, slittando, chiedendo all’erba più asciutta la bontà di tenerci stretti.
Il Giardino della Festa è il primo dei passaggi, è dove ci fermiamo.
A guardia di questo piazzale erboso c’è Maia di Umaia, giovane cavalla di quasi tre anni, una bretone da tiro che aiuta la comunità nei lavori negli orti e nei terrazzi.



Maia è placida. In Toscana è stata addestrata a non aver paura del bilancino, del rumore di ferraglia, delle corde che la vestono. Lavora in piano, ove possibile. In vigna non è ancora di supporto ma lo sarà presto, presa la dovuta confidenza coi mezzi.
Da qualche tempo Maia è chiusa in recinto per via dei lupi. È capitato che attaccassero anche bestie grosse, grosse come cavalli. In zona sono diventati sinonimo di grossi guai. Hanno sbranato il cane di Enio Ferretti e attaccato anche vacche e puledri.
Il lupo, dice Felicia, comincia a farsi problema, si avvicina in maniera preoccupante, non ha paura, non riconosce l’uomo come predatore, come cacciatore, come nemico. A Giulio Acquati, socio fondatore di Umaia, è capitato di incontrarlo sulla strada, di notte, in moto. La bestia non ha indietreggiato, non si è intimorita, neanche al rombo del motore, al clacson, neanche di fronte all’uomo. Non bastasse ci sono caprioli e cinghiali, affamati, devastanti, peggio delle cavallette.
Maia sta prendendo l’abitudine a dirigere l’erpice a maglie. Non è la prima volta che a Umaia è impiegato un animale come forza da traino. È una scelta precisa, è ulteriore forma del mosaico di follie che Umaia persiste a comporre. Lavorare a mano, il più possibile. Non cedere ai costi della meccanizzazione del mestiere, men che meno alla sua digitalizzazione. Zappare, arare, seminare, sfalciare in un modo che è arcaico. Non è integralismo, in certi casi ne farebbero anche a meno, ma i mezzi costano, costa la manutenzione, costa la modernità.
Una volta fatta questa scelta si sono resi anche conto che lavorare a mano rende meglio, permette un rapporto diretto corpo/mansione da fare. Si comprende meglio, si conosce a fondo, si affronta e si risolve. Limitare l’ausilio di mezzi a motore ha come ulteriore conseguenza l’impegno a lavorare coralmente, in tanti, insieme. La solitudine è una cosa impossibile in certe fasi. In questi tempi di grande individualismo è una delle grandi sfide che qui si compiono, forse più faticosa del lavoro fisico. È un equilibrio in più su cui concentrarsi, insieme allo svolgimento dei compiti, delle mansioni, al capire il proprio ambito nella gestione delle competenze. Issare pesantissime travi, costruire teche per riporre le bottiglie, zappare, falciare, portare i vini in enoteca, curare l’orto, le galline, seminare e raccogliere.

LA FRANCI, LA TERE, LA CATE, GIULIO
Nata nel 2021, Umaia oggi è composta da un nucleo di cinque/sei persone intorno alle quali ne girano molte altre, in aiuto, supporto, per riparo. Il nucleo è costituito da Felicia, Giulio, Teresa, Caterina, Francesca, e poi da altre figure, affettive, importanti e necessariamente lì dentro: Oscar, le bambine e i bambini, Fulvio, Elia, Viola, Bruno.
La casa, grande, tra le più antiche di Cornigliasca, è stata acquistata da Giulio. Sette ettari totali, bosco incluso. L’hanno ristrutturata.
Ove possibile le mansioni sono divise secondo competenza. Giulio e Felicia si occupano delle vigne. Le altre lavorano dove serve, tra semina e raccolta, in orto, nel pollaio, nella cura.
Solo di Umaia, però, non si campa, gli unici due mezzi redditi che riescono a sostenere sono quelli di Felicia e di Giulio. Le altre persone hanno un altro lavoro a sostegno. Francesca è ginecologa, Teresa è medico di base, Caterina lavora in cantina a Valli Unite. Oscar lavora da Enio Ferretti. La stessa Felicia segue i cavalli in un’azienda vicina.
Ma c’è quello che serve. Umaia, comunità, si è messa profondamente alla prova istituendo una cassa comune, che raccoglie stipendi e risorse. È una prova estrema, un’altra follia, una grande risorsa di umanità, un atto di coraggio enorme.
Sul leggero crinale della collina scorgiamo l’auto di Oscar. Porta Elia, piccolo di Felicia che in Umaia sta crescendo tra persone adulte e infanti. Ci raggiungerà di corsa, scivolando soddisfatto.
Il Giardino di Maia è il luogo in cui cercano di passare più tempo possibile, nella bella stagione soprattutto. È un luogo di festa ove lavorare, scortecciare, fare legna.
Oltrepassiamo qualche filare di canne piantato per farne tutori per le piante, viti comprese.


Nel passaggio verso le vigne sostiamo avanti la piccola uliveta. Settanta piante messe giù a marzo del 2024. È una sperimentazione in campo: tra le varietà messe a dimora si sceglierà quella che meglio regge quella esposizione così singolare.
Guardiamo attorno, ascoltiamo Francesca e Felicia. L’organizzazione delle terre e delle fatiche di Umaia segue una geometria di sussistenza. L’orto estivo, lavorato con Maia; gli alberi da frutto (piantati subito, appena arrivati, nel 2021), le mandorle, i meli, le susine, gli aceri, cachi e ciliegi, fave, aglio e cipolle, i ceci, il grano, il farro, l’avena, i pomodori, il fieno. La vigna.
La vigna, in questi ultimi anni, in zona, è una grande incognita.
A Umaia quella a timorasso è stata piantata nel 2022.
Oltre a quella, hanno in gestione alcune vigne altrimenti in abbandono a Carezzano.
Nel 2024, quelle a timorasso non hanno dato nulla, dilaniate dalla peronospora nel giro di poco, nonostante si sia cercato di proteggerle. Con tanta fatica e molte preoccupazioni, si cerca di sperimentare, di risolvere. Varietà che sopportino queste aggressioni crittogamiche, qualcosa che possa valorizzare a pieno quel luogo, quel lavoro, quella posizione. Come in certe fotografie volutamente sottoesposte, quando i colori esplodono dal buio.
Il suolo è argilloso, di argilla mista a sabbia fine e calcarea, in parte si traduce in vene bianche chiare, in altre tende al rosso, e qui, dice Feli, le piante sono molto più vigorose e fitte. In certi punti emergono affioramenti di gesso, anche in forma di grosse pietre squamose.
Per l’età di Giulio e Teresa l’impianto a timorasso è rientrato nei finanziamenti del PSR (Programma di Sviluppo Rurale), insieme ai lavori di allestimento della cantina. Accedere al fondo non è stato semplice. È stato necessario lavorare di carte. Una fatica e un impiego di tempo non preventivato che si è aggiunto alla mole di lavoro fisico affrontato quotidianamente. Malgrado sia andata in porto, benché sia stato verificato e collaudato, il saldo del finanziamento non è ancora chiuso.


Nella piccola cantina, pulita e ordinata, gli affioramenti di gesso sono evidenti, anche se coperti di calce e pittura.
Hanno ristrutturato quei locali con le loro mani, organizzato gli spazi secondo necessità. Quando Giulio ha acquistato la casa, lì sotto c’erano solo terra e macerie. Null’altro.
Per le uve, neanche a dirlo, la pigiatura è fatta tutta coi piedi, soffice, nessuna pigiadiraspatrice. Tutta così, è il caso di sottolinearlo, non solo il pied de cuve, il piede di fermentazione.
Se il primo anno hanno prodotto settemila bottiglie, nel 2024 ne hanno portato a casa solo cinquemila.
Se andrà bene, proveranno ad arrivare a diecimila, per dare un senso al reddito di tutti. Diecimila è una misura ancora gestibile perché poi occorre andare a venderle, muoversi verso, farsi pagare, ed è un altro mestiere. E tocca a Felicia.
UN’ISOLA FELICIA
Felicia Carotenuto la conosciamo da anni, è la nostra finestra su Umaia. Per consuetudine è il primo volto che associamo a questo progetto. Con Felicia abbiamo condiviso un periodo di vicinanza stretta, tra Albairate, Abbiategrasso e Folletto25603. Abbiamo cominciato a conoscere così i suoi sogni, il desiderio di coltivare, di costruire, di cambiare se stessa e le cose, senza capitalizzare. Lei e Gabriele Patriarca covavano il desiderio di coltivare tra il Parco Agricolo Sud Milano e il Parco del Ticino. Per un periodo hanno fortemente cercato un approdo qui, un luogo in cui insediarsi. Ma i prezzi delle terre, delle cascine, erano già gonfi di gentrificazione, di Milano a due passi e milanesi in gita fuori porta, di B&B, strutture ricettive. Rinunciarono a Milano e alla sua provincia nel 2013, per dirigersi verso queste terre, ove la misura economica era di certo più umana e accessibile. Da quel momento, per Felicia sono iniziati anni di sperimentazione, di forte messa in discussione, di duro lavoro, di sogni felicemente folli.
Prima che andasse via da Abbiategrasso, con lei, grazie a lei e a Gabriele Patriarca, al Folletto25603, costruimmo il più grande dondolo di legno mai visto prima. Una struttura enorme che installammo quatti quatti un tardo pomeriggio nel parco comunale del quartiere Folletta; corsari su trattore e braccio escavatore, agghindati come ingegneri, tecnici improbabili. Quel possente trabiccolo, quella felice follia, fu un successo enorme, cavalcato per anni da bambini, ragazzi, famiglie; talmente bello che lo stesso comune si prestò alla sua manutenzione quando si fece necessaria, sostituendo le nostre vecchie con due grandi maniglie smaltate di rosso.
Se la vita vi porta a Cornigliasca, bussate alla porta di Umaia. C’è molto altro da scoprire.
Portate gli stivali.
Da L’Almanacco de La Terra Trema. Vini, cibi, cultura materiale n. 35
20 pagine | 24x34cm | Carta cyclus offset riciclata gr 100
Per ricevere e sostenere questa pubblicazione: info@laterratrema.org
Last modified: 28 Mar 2025