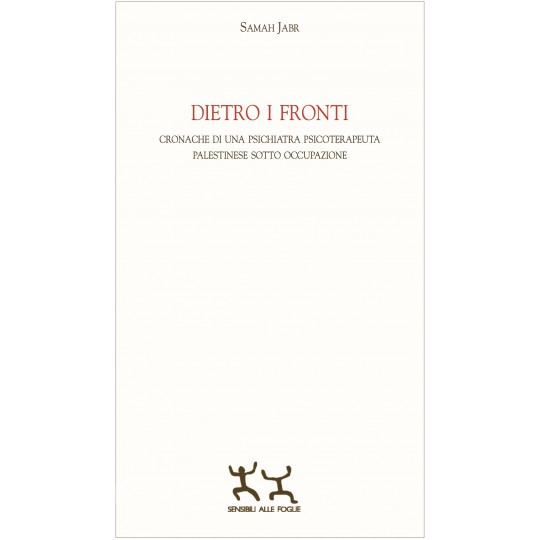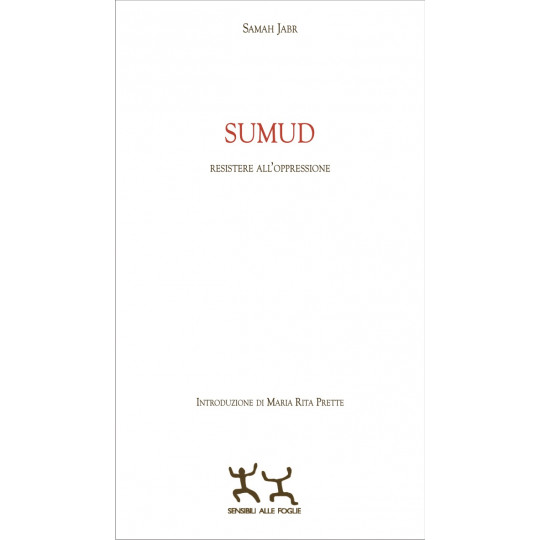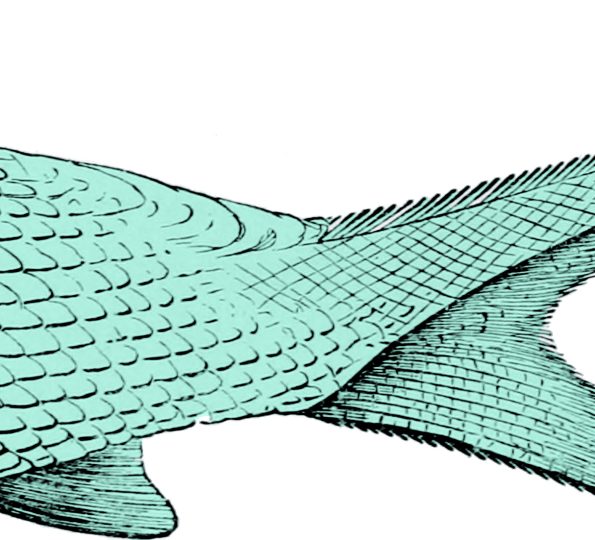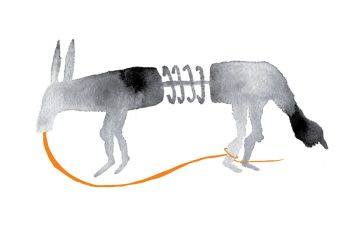SAMAH JABR E IL TEMPO DEL GENOCIDIO
di Maria Rita Prette – Sensibili alle foglie – gennaio 2025
disegno di Roberto C.
«Non si insisterà mai abbastanza sugli effetti terapeutici della solidarietà internazionale per i palestinesi. Per un popolo che ha sopportato decenni di sfollamento forzato, espropriazione e violenza, la consapevolezza di non essere solo nella sua lotta è fonte di conforto e di incoraggiamento. Questo riafferma la nostra umanità di fronte alla disumanizzazione e offre un barlume di speranza per un futuro libero dall’oppressione. Come psichiatra, io credo nel potere curativo della solidarietà. I suoi benefici sono reciproci, arricchendo sia chi dà sia chi riceve».
(Samah Jabr, Il tempo del genocidio, p. 105)
Nascere in una terra già occupata da tre decenni e, sin dall’infanzia, imparare a vivere in un contesto traumatico, che si nutre di violenza e disuguaglianze, e ciononostante costruire un passo dopo l’altro – dagli studi all’estero alla pratica clinica critica – una carriera professionale di altissima qualità come Samah Jabr ha fatto, credo sia sufficiente a tratteggiare la forza e la determinazione che caratterizzano questa donna coraggiosa, che scrive per guarire le ferite collettive della sua gente e per testimoniare la patogenicità dell’occupazione militare e della segregazione razziale imposte da Israele sulle vite palestinesi.
Samah vive a Gerusalemme Est, è professoressa associata di Psichiatria e Scienze Comportamentali presso la George Washington University di Washington DC e ha elaborato, a partire dalla sua esperienza professionale, uno sguardo critico verso le categorie psichiatriche occidentali, ritenendole inadeguate ad affrontare il reiterato trauma che si è accumulato – e trasmesso di generazione in generazione – nella società palestinese.
Tra le sue competenze, la formazione al Protocollo di Istanbul (il “Manuale per indagare efficacemente sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti”, pubblicato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite in sei lingue nel 2005). Una necessità professionale legata alla frequenza con la quale i suoi “pazienti” si trovano a fare i conti con le conseguenze delle torture subite nelle carceri israeliane e con i trattamenti disumani e degradanti a cui sono sottoposti tutti i palestinesi quando vanno al lavoro, a scuola o in ospedale – nei territori in cui esistono ancora, vista la distruzione radicale operata nella Striscia di Gaza e l’annessione progressiva e ignorata della Cisgiordania. D’altra parte, è una istituzione israeliana ad aver documentato la rete dei campi di tortura istituiti da Israele per il “trattamento” dei prigionieri palestinesi. Prigionieri che in una certa percentuale sono determinati dalla “detenzione amministrativa”, quella che in Italia viene usata contro gli immigrati. In sostanza, una detenzione che non prevede alcuna accusa, né la formulazione di una fattispecie di reato. Persone prese in ostaggio, sostanzialmente. B’tselem nel rapporto “Welcome to hell” (“Benvenuti all’inferno“, pubblicato nell’agosto 2024 e disponibile sul sito www.btselem.org) riporta le testimonianze di cinquantacinque detenuti e conclude la sua indagine con parole pesanti come pietre: «I prigionieri formano un ampio spettro di persone provenienti da aree diverse, con opinioni politiche diverse. L’unica cosa che hanno in comune è essere palestinesi. […] Al momento in cui scriviamo (agosto 2024) più di 9000 persone – palestinesi classificati come “prigionieri di sicurezza” – sono detenute da Israele in una rete di campi di tortura, sottoposti alle condizioni e agli abusi descritti in questo rapporto. Questa realtà è inaccettabile e riempie noi, israeliani e palestinesi che crediamo nella giustizia, nella libertà e nei diritti umani, di vergogna, ansia e rabbia. Facciamo appello a tutte le nazioni e a tutte le istituzioni e gli organismi internazionali affinché facciano tutto ciò che è in loro potere per porre fine immediatamente alle crudeltà inflitte ai palestinesi dal sistema carcerario israeliano e per riconoscere il regime israeliano che gestisce questo sistema come un regime di apartheid che deve giungere al termine».
Samah, infine, scrive per guarire anche le nostre ferite, quelle dell’impotenza in cui ci ha gettati la crudeltà esplicita e spettacolarizzata con la quale Israele e gli Stati suoi complici hanno fatto terra bruciata di Gaza, di qualsiasi diritto internazionale e di quanti hanno cercato di opporsi allo sterminio manifestando la loro solidarietà con la Palestina. A questi ultimi è dedicato il capitolo “Coltivare la resilienza”.
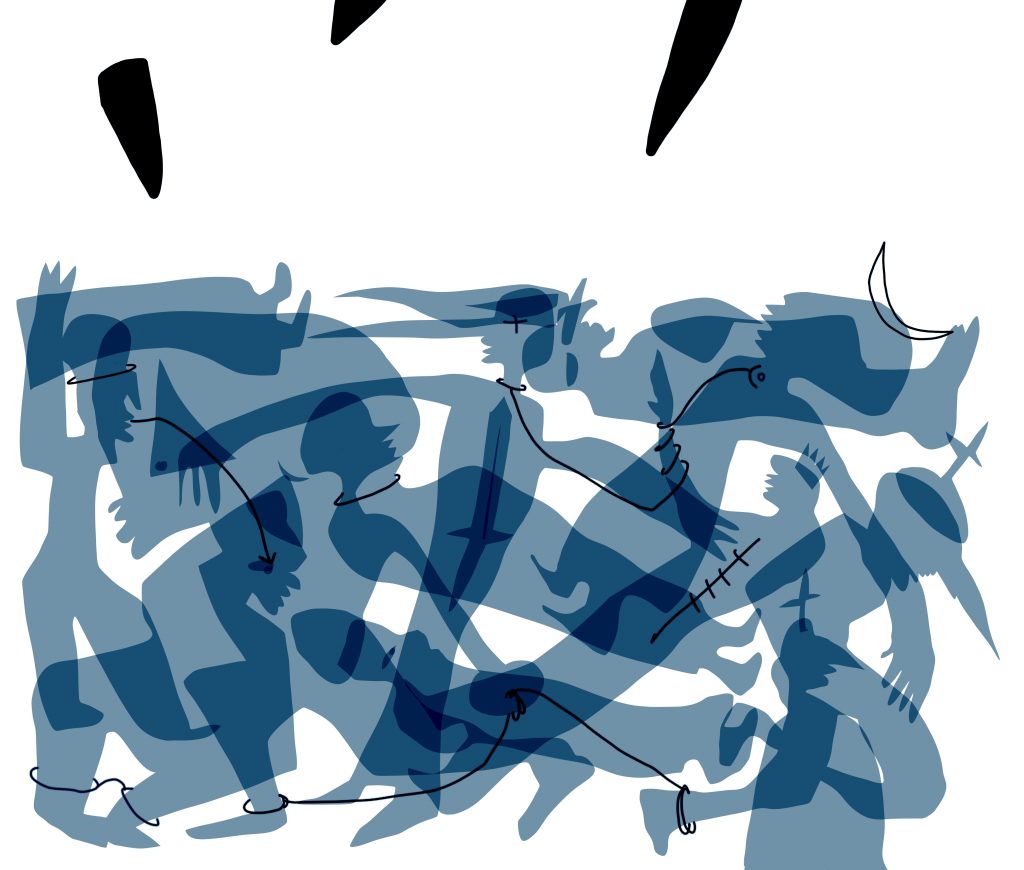
COLTIVARE LA RESILIENZA
Samah Jabr (in Il tempo del genocidio, traduzione di Cloe Curcio, Sensibili alle foglie, 2024 pp. 123-128)
5 luglio 2024
L’impatto psicologico dell’attivismo contro l’oppressione, il tributo psicologico pagato dagli attivisti e dai difensori della libertà che lavorano e vivono in regioni assediate da occupazione, colonizzazione e oppressione, può essere immenso.
L’esposizione costante alla violenza, alla perdita e al trauma può avere implicazioni psicologiche profonde, che includono ansia, depressione, stress traumatico, stanchezza emotiva e burnout. La psiche degli attivisti è continuamente bombardata di informazioni, immagini e ricordi che infrangono la loro pace mentale, generando sofferenza e ferite morali. Anche quando sfuggono a minacce dirette e ritorsioni, assistere ad azioni orribili che violano le proprie convinzioni etiche può generare un senso di impotenza, colpa, vergogna, confusione e innescare una crisi identitaria. Per coloro che si battono per la giustizia il conflitto morale tra azioni necessarie e valori profondamente sentiti può risultare particolarmente tormentoso.
Alcuni attivisti sopravvivono e altri no, spesso provocando nei sopravvissuti un senso di colpa che li spinge a domandarsi perché essi siano ancora in vita quando altri sono caduti e rendendo difficile trovare la pace o sentire di meritare le piccole gioie della vita.
Sumud: l’essenza della resilienza palestinese
Nel contesto della lotta palestinese il concetto di sumud – fermezza o perseveranza – incarna lo spirito della nostra resistenza. Sumud non è solo sopportare la difficoltà, bensì mantenere la nostra identità, la nostra dignità e un atteggiamento di sfida contro l’oppressore, oltre alla speranza per la libertà a scapito dell’implacabile oppressione. Il sumud si può applicare alla salute mentale e al benessere di coloro che resistono alla repressione di Stato e combattono per la libertà in tutto il mondo. Ci insegna a restare saldi, a trarre forza dalle nostre radici e a credere nella possibilità di un futuro giusto. Sumud è trovare forza nella comunità, nelle nostre difficoltà condivise, nell’irremovibile convinzione che la giustizia prevarrà.
Per gli attivisti, abbracciare il sumud significa coltivare la resilienza, incentivare la solidarietà e promuovere la speranza. È la promessa di non arrendersi, nemmeno nei momenti di debolezza, finché non si trova la forza di rialzarsi in nome della propria causa e di riprendere a lottare per un mondo migliore.
Attraverso il sumud rendiamo onore al passato, viviamo appieno il presente e rimaniamo dediti a un futuro di libertà e giustizia.
La mia prospettiva personale, in qualità di psichiatra in Palestina, di restare a galla tra il trauma pervasivo e la violenza continua è un processo complesso ma profondamente radicato.
Sono nata in un contesto traumatico, perciò le mie difese e i miei meccanismi di salvaguardia si sono sviluppati naturalmente e con costanza nel corso della mia vita. Questi meccanismi non sono solo la mia via di sopravvivenza personale, sono una testimonianza di sumud che mi definisce come palestinese.
Nel dettaglio, la fede gioca un ruolo centrale nella mia vita. Percepisco la cura e la misericordia di Allah che mi guidano durante i momenti più difficili. Questa fede non si limita a darmi forza e sollievo, mi instilla anche un senso di scopo e responsabilità.
Credo fermamente che la causa palestinese sia giusta e nobile e sono orgogliosa di difenderla. Penso che sarebbe lo stesso anche se non fossi palestinese. Credo che sia un esempio profondo di confronto tra diritto e potere, una realtà comune che può essere esperita dappertutto. In questa lotta l’esempio è palestinese ma la lezione è globale. Questa convinzione incentiva il mio senso di responsabilità e accende la mia perseveranza e determinazione.
La mia famiglia, che mi offre supporto, e i miei affidabili amici sono le chiavi di volta della mia forza. Essi mi danno una rete di supporto emotivo, di comprensione e incoraggiamento, essenziali nel quadro delle attuali avversità. Condividiamo un legame comune e la comprensione delle nostre difficoltà, che rinforza la nostra risolutezza collettiva.
Per me la mia professione è più di un semplice lavoro, è una vocazione che mi permette di essere d’aiuto alla mia comunità. Aiutando altri a guarire trovo uno scopo ed evito di restare paralizzata dall’impotenza traumatica che si cerca di infliggerci, qui in Palestina.
Questa partecipazione attiva al processo di guarigione rinforza la mia partecipazione e il mio senso di agency. In ultima analisi, faccio ciò che ritengo di dover fare nella mia vita, guidata da un profondo senso di scopo e dall’accettazione delle conseguenze. Questa accettazione mi dà conforto, anche nel cuore del tumulto.
Integrando la mia fede, il supporto della famiglia e degli amici e il mio scopo professionale navigo le immense sfide del mio lavoro e della vita in Palestina con un cuore resiliente e uno spirito speranzoso.
Comprendo che la Palestina si trova in un travaglio difficile e doloroso, ma la nostra liberazione verrà un giorno.
Naturalmente ci sono molti momenti difficili.
Quando mi sento stanca, triste o in lutto trovo pace particolarmente nella connessione con la terra. Il mio percorso verso la guarigione, nel trauma pervasivo dell’occupazione, mi ha avvicinata alla pratica umile ma profonda del giardinaggio. Il rifugio delle foglie fruscianti e dei fiori sbocciati è diventato il mio santuario, offrendomi una tregua dai racconti tormentosi di tortura e sofferenza che incontro quotidianamente nella mia professione. I video di giardinaggio mi hanno inizialmente aiutata ad archiviare le immagini residue di orrore e i ricordi. Quando mi sono trasferita in una casa con un’assegnazione di terra ho abbracciato questa pratica a tutto tondo e ho cominciato a piantare i miei ortaggi e frutti.
In seguito alle strazianti perdite inflitte dal genocidio in Palestina il giardinaggio è diventato più di un hobby, trasformandosi in un’àncora di salvezza. È diventato un rituale sacro attraverso il quale entro in connessione con la terra e rendo onore ai caduti.
Nel quadro di una brutale strategia politica mirata a trasformare la fame in un’arma, coltivare il mio cibo è un atto di grande sfida.
Le forze occupanti cercano di affamare il nostro popolo per spingerci alla sottomissione. Ogni seme che pianto è una ribellione contro questa tattica oppressiva, una dichiarazione della volontà palestinese di vivere, di nutrirsi e di resistere. Ogni seme piantato è una preghiera per i caduti, ogni bocciolo un tributo al loro spirito di sopportazione. Il giardino è diventato un microcosmo di sumud e resistenza. Ogni ortaggio che germoglia e ogni frutto che matura è una testimonianza della nostra resilienza. Nulla viene sprecato: gli avanzi sono compostati, arricchendo il suolo che, a sua volta, ci sostiene.
Questo ciclo di crescita e rinnovamento è una potente contro-narrativa alla distruzione e alla disperazione che ci vengono imposte. Lavorando il terreno con le mie mani sento una profonda connessione con la terra sotto di me, una connessione che trascende la mera realtà fisica e sfiora l’essenza dell’esistenza. Nel suolo fertile vedo i corpi preziosi dei martiri, intrecciati alle radici delle piante, le loro anime che si mescolano con i boccioli fragranti che adornano il giardino.
Ogni mattina, quando le prime luci dell’alba baciano l’orizzonte, sono solita camminare tra le file di ortaggi e fiori, prendendomi teneramente cura di ogni pianta, come se fosse un’anima cara. E quando il sole tramonta dietro l’orizzonte, mostro la mia riconoscenza alla terra che è diventata il mio porto sicuro, il mio tempio, la mia compagna di lutto. Il mio giardino è un promemoria che anche nei momenti più bui la vita trova un modo per tornare a sbocciare, che dalle ceneri della distruzione può ancora emergere qualcosa di bello.
Osservare le stagioni, sperimentare la perdita e la morte in questo contesto naturale e assistere a nuove crescite mi trasmette un profondo senso di radicamento. Mi ricorda della continuità della vita e della speranza propria della natura.
Altre strategie per il benessere mentale e la guarigione
Mentre io trovo la mia mindfullness e il mio spazio di meditazione nel quadro del giardinaggio, altri possono trovarli nella preghiera, nel riposo, nella contemplazione, etc. Tecniche come la respirazione profonda, il rilassamento muscolare progressivo e la visualizzazione guidata possono essere benefiche per molti. Queste pratiche ci ancorano al presente, offrendo una tregua dall’incessante sfilata dei ricordi traumatici.
Per alcuni è essenziale costruire e mantenere forti legami comunitari. Condividere esperienze, offrire supporto reciproco e incoraggiare un senso di solidarietà può mitigare sensazioni di isolamento e impotenza. Lavorando insieme gli attivisti ottengono sinergia, traendo forza dalla resilienza gli uni degli altri e dal perseguimento di uno scopo comune.
Svolgere attività creative come la scrittura, l’arte, la musica e la danza può servire come potente sfogo per processare le proprie emozioni e per esprimere l’inesprimibile. L’arte trasforma il dolore in bellezza, dando voce al non detto e rinnovando un senso di soggettività e agency.
Talvolta ricorrere a un supporto professionale per la salute mentale, come cercare supporto tra pari, iniziare un percorso di terapia o counseling, può offrire un aiuto inestimabile.
Le organizzazioni per i diritti umani e i gruppi di solidarietà dovrebbero battersi per offrire accesso a risorse di salute mentale per gli attivisti e stabilire ambienti in cui gli attivisti si sentano sicuri di poter condividere le proprie esperienze ed emozioni senza timore di essere giudicati. Gli spazi sicuri stimolano un dialogo aperto e favoriscono la moderazione.
Occorre incoraggiare una cultura che dia priorità alla cura di sé e al supporto reciproco, riconoscendo che prendersi cura di sé è fondamentale per sostenere la lotta per la giustizia, e promuovere una cultura che validi il riposo e il recupero. È altrettanto importante che ogni attivista riconosca i propri limiti e metta dei confini per evitare il burnout.
È essenziale fare pause regolari e garantirsi il tempo per riposare e prendersi cura di sé. Mentre rifletto sui frutti e sugli ortaggi che raccolgo dal mio giardino mi sovviene il proverbio francese: “chacun fait sa cuisine interne”, che significa “ognuno crea la propria cucina interiore”. Questa metafora allude alla miscela unica di ingredienti che contribuiscono al nostro benessere. Per gli attivisti è fondamentale ricordare che il benessere personale è essenziale al fine di sostenere le nobili cause di cui si fanno paladini.
Ognuno di noi deve trovare il giusto equilibrio di pratiche che coltivano la nostra resilienza e il sumud, permettendoci di proseguire la battaglia per la giustizia con vigore e lucidità.
I libri di Samah Jabr pubblicati da Sensibili alle foglie:
Da L’Almanacco de La Terra Trema. Vini, cibi, cultura materiale n. 35
20 pagine | 24x34cm | Carta cyclus offset riciclata gr 100
Per ricevere e sostenere questa pubblicazione: info@laterratrema.org
Last modified: 26 Mar 2025