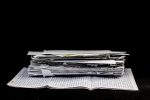Testo e immagini di Alessandro Cagni e Viviana Insacco
Nel dicembre del 2024 il piccolo villaggio di Tifnit, in Marocco, svanisce, spazzato via dalle ruspe, dal turismo mastodontico, dall’ennesimo devastante «grande evento».
Atterriamo ad Agadir, città ricostruita dopo il terremoto del 1960 e immacolata in un meticoloso rigore architettonico, con ampi viali e una scenografica spiaggia a mezzaluna. Le dedichiamo una passeggiata, per amor di cronaca e del sole che affonda placido, ma l’idea di una città detersa nel nome del turismo internazionale annoia profondamente
A sud il paesaggio dirada e noi soggiorniamo qui, una zona che non offre particolari attrattive se non un’area naturalistica tra i fiumi Souss e Massa che è habitat di gazzelle e varie specie di uccelli. Lo scenario che corre identico per una trentina di chilometri è fatto di sabbia, pietre, capre che pascolano tra ciuffi di spine e un mosaico di serre per la coltivazione dei pomodori. In fondo romba l’oceano col suo susseguirsi di spiagge selvagge poco accessibili. Decidiamo di raggiungere Tifnit, un villaggio di pescatori indicato dai cartelli stradali. La luce è abbagliante, oceano sole e sabbia esplodono in un tutto luminoso. Parcheggiamo in prossimità di un edificio semi abbandonato, sede di una cooperativa di pesca. Non vediamo però Tifnit, eppure anche Google Maps dice perentorio che siamo arrivati a destinazione.

Subito il “parcheggiatore”, scesi dall’auto, saluta e racconta d’esser stato un abitante del villaggio e cerca di mostrarci, attraverso lo schermo scheggiato del suo cellulare, le foto di quello che c’era: il villaggio si estendeva abbarbicato sulla scogliera, esattamente sotto i nostri piedi. Nella raffica di invocazioni, capiamo che il governo ha spazzato via tutto con le ruspe.
Addentriamo un po’ lo sguardo e, in effetti, la sabbia è mista a detriti e un paio di ingressi scavati nella roccia si stagliano ancora poeticamente verso l’orizzonte atlantico.
Ci raggiunge serafico un signore che gestisce i tre tavolini di plastica davanti alla cooperativa dove più tardi mangeremo un vassoio di sardine grigliate sotto un ombrellone arrugginito. Parla di un hotel che vorrebbero costruire proprio lì, per i mondiali di calcio del 2030. Increduli, abbozziamo un’intervista in un francese basico e scopriamo che il 25 dicembre, con appena cinque giorni di preavviso, Tifnit è stato raso al suolo. Niente indennizzi, più verosimilmente multe e denunce per l’occupazione del demanio marittimo. Ma grazie a Dio siamo in salute, conclude con un fatalismo che sembra innato, pregandoci di usare il video solo in famiglia perché già mi hanno tolto la casa, non vorrei che mi togliessero anche il ristorante.
Più tardi facciamo una ricerca in rete e vediamo apparire le immagini di Tifnit. Ristori con terrazzini bohémien, intrichi di reti da pesca tra le barche bianche e blu, angoli dai colori variopinti. Le stanze spartane con vista mare sono ancora su Booking e in vari blog per surfisti il posto è raccomandato come un paradiso. Ripetiamo la ricerca usando parole francesi e spuntano anche poche, pochissime notizie sui giornali online che citano la demolizione delle “case anarchiche”. Erano fatiscenti, costruzioni abusive. Addirittura ci hanno speculato, rivendendo gli immobili senza essere proprietari dei relativi titoli. Il piano Reale di Mohammed VI è ripulire la costa atlantica da questo scempio.
Che siano gli eventi calcistici in arrivo nel 2030 (prima la Coppa d’Africa, poi la Coppa del Mondo) o l’abusivismo edilizio, non lo abbiamo capito certo bene. Ma qualunque cosa sia è solo l’inizio: ci troviamo nel bel mezzo di una colossale operazione di riscrittura dei luoghi.
Nel continente africano i luoghi si scrivono, si cancellano e si riscrivono senza tanto clamore, guarda caso anche Kapuściński, che stiamo rileggendo in questo frangente, racconta della temporaneità come un tratto comune. A quanto pare «tutte le comunità di questo gigantesco reticolato, che è la popolazione africana, occupano territori sui quali in passato non abitavano. Provengono tutti da qualche altra parte. Sono tutti immigrati».
Eppure questa provvisorietà nel nostro sistema di pensiero suscita un rigurgito d’indignazione. Possibile che sia scomparso un paese dalle mappe ufficiali? Erano case semplici tirate su alla buona, è vero, ma ci viveva della gente che ci cavava fuori il giusto per sopravvivere e lavorare, magari con la sensazione di sfuggire un po’ ai ricatti e alla pesantezza di arrabattarsi in contesti urbani assurdi per tirare avanti.

Pochi chilometri più a nord la baia dorata di Agadir continua, imperterrita, la sua vita con i resort e la polizia turistica sulla Corniche.
Sono i primi di febbraio quando svoltiamo verso Imsouane, altro villaggio di pescatori noto ai surfisti di tutto il mondo. Sappiamo di non essere più in tempo: la sua demolizione era prevista per il 17 gennaio. Quando arriviamo, il ragazzo che avevamo preso a bordo (l’autostop è molto usato dai marocchini), ci indica l’enorme buco rimasto tra la spiaggia e le case nuove nella retrovia: qui c’era lo snack bar di suo padre, insieme ad altri duecento immobili. I bulldozer stanno completando l’opera sul lato sinistro, in una nuvola di sabbia fine che si solleva sullo spiazzo spettrale. Difficile immaginarsi l’accavallamento di case, alcune antiche di centoventi anni, che componevano il centro storico di Imsouane. Anche qui, il motivo ufficiale è l’occupazione abusiva del demanio marittimo. Anche qui, i residenti ritengono che l’intenzione del governo sia costruire moderni complessi alberghieri.
Sono rimasti due bar dove si affollano i surfisti non aggiornati sul destino della loro Mecca, anche Forbes annovera la spiaggia come una delle ventisette più belle al mondo. Degustano healthy breakfast a prezzi molto sopra la media e, in tutta onestà, non appaiono particolarmente coinvolti.
L’ascesa del surf in Marocco ha portato così tanti vantaggi economici da inserirsi in una complessa dinamica di causa effetto. I villaggi che più ne hanno beneficiato finiscono per essere distrutti e il popolo delle tavole che arriva con i voli low cost, degni di una tesi di antropologia come subcultura transnazionale specifica, sembra avere qualche responsabilità. Il campione di surf Joel Tudor all’indomani della distruzione di Tifnit si sfoga su Instagram: «Tutti voi svitati con i vostri ritiri di yoga, surf camp e riviste online che avete fatto saltare in aria questo posto […] spero che siate felici ora. Lo avete appena ridotto in macerie per renderlo presto di fascia alta». In un altro post scrive: «ora stanno tutti firmando petizioni e condividendole sui social media. Ci sono stato dieci anni fa, da allora tutti i social hanno violentato quel posto. Ora sono molto sorpresi che il governo sia solidale con i grandi fondi fiduciari e le catene alberghiere… anche un gruppo di famosi longboarder, con i loro ritiri di migliaia di persone che guadagnano senza collaborare con la gente del posto. Vergogna».

L’impatto del turismo surfistico lo vediamo bene a Taghazout, che per fortuna abbiamo modo di visitare ancora intatto. Forse sarà il prossimo, la sua demolizione è ventilata da luglio. È un villaggio molto grazioso e ci vengono i brividi. Eppure l’identità locale è in un equilibrio visibilmente precario: circola una popolazione fitta, giovanissima e prevalentemente bionda, che affolla ogni viuzza, ogni locale, difficile trovare un tavolo libero. Solo al tramonto i vecchi nei loro gellaba si riappropriano della spiaggia: fumano appoggiati a una barca con lo sguardo al mare, oppure giocano a carte attorno a una cassa rovesciata.
Eppure quello che dice Lachen, un ragazzo che abbiamo raggiunto dopo un paio di chilometri di pista nel parco nazionale di Tamri, è che i surfisti in realtà non amano il lusso e queste strutture saranno destinate a rimanere vuote.
Lui ha rimesso a posto la grotta ereditata dal nonno in un villaggio di sei pescatori. Si respira un equilibrio perfetto tra uomo e natura, cuciti insieme con senso artistico. Mentre mangiamo un’omelette sotto la tettoia di palme, osservando la marea che infuria sulle rocce, ci confida di sperare che la presenza su queste dune isolate dell’ultima colonia rimasta di Ibis eremita freni l’arrivo delle ruspe. Ride mentre ringrazia teatralmente il dio uccello ma non è poi così sicuro. «Intanto metto via qualche soldo, poi si vedrà». Quanto al nostro proposito di scriverne ci guarda perplesso, timoroso di attirare su di sé l’attenzione. Come abbiamo riscontrato anche altrove, la reazione più comune alla minaccia sembra essere l’inibizione dell’azione. Farsi piccoli, fingersi già morti.


Ma altrove prevale un netto consenso. Nell’oasi di Tarmguist il vecchio Hassan, con loquacità appassionata, ci racconta dello sviluppo agricolo di Tarmguist in una condizione di stress idrico ormai permanente. Dietro il turbante i suoi occhi brillano mentre snocciola date, classifiche e progetti che descrivono un Marocco virtuoso nella lotta ai cambiamenti climatici. Stravaccati nella sua tenda bevendo tè, lo ascoltiamo per ore rapiti dal suo trasporto.
Quando gli chiediamo un parere sulle demolizioni il suo sguardo però si affila. Sente l’intento polemico e taglia secco: «E’ semplice, la spiaggia appartiene a tutti, nessuno può costruirci sopra». Vorremmo fargli altre domande ma da un angolo della tenda una foto incorniciata del Re ci ammonisce: è terreno scivoloso, c’è di mezzo la devozione sincera di un popolo. Ed è vero, non possiamo afferrare del tutto le logiche di questa genesi.
Anche Mohammed, maestro di surf di Mirleft, approva l’operato del Re, e la cosa è paradossale perché la sua casa è tra quelle demolite. Non si sottrae alle nostre domande e argomenta il sogno di modernizzazione del Marocco con grande precisione: le case erano prive di fognature, inquinavano, la villa a fianco alla sua occupava l’intera spiaggia. Il governo costruirà strutture in legno e vetro, molto più sostenibili. Parla anche di business spregiudicati e diritti dei lavoratori. Guarda questi ragazzi, dice indicando il viavai di giovani berberi sulla spiaggia di Legzira mentre servono tajine a piedi scalzi: «Che futuro possono avere? Per il povero Abdul che si è ammalato di cancro abbiamo dovuto fare una colletta».

Tornare sulla spiaggia di Legzira dopo venticinque anni, comunque, è stato uno shock. Laddove era solo oceano, scogliere, sabbia, un pescatore con la sua grotta e al più qualche ragazzo che s’imboscava lontano con una lattina di birra, ora un conglomerato di piccoli edifici con poca grazia, rudimentali dehors, tavoli di plastica sul bagnasciuga e un gregge di rumorosissimi quad a utilizzo di qualche coglione occidentale ma soprattutto di alcuni spietati turisti marocchini. Il brum brum è abbastanza continuo e si frappone al suono ritmico delle onde, il tutto per soddisfare una richiesta assurda: quella di percorrere i 500 metri che portano al maestoso arco sul mare, attrazione indiscussa della provincia di Sidi Ifni. Il nostro sbigottimento, capiamo con una lucidità frustrante, è pari ma contrario a quello provato a Tifnit e Imsouane.
Anche qui lo spettro delle ruspe Reali è in agguato sulla micro economia che si è fatta strada, anarchicamente, attorno a una risorsa naturale.
Eppure quello che verrà dopo le demolizioni, che si susseguiranno per tutto il 2024, è tracciato con chiarezza. Sulla spiaggia di Tamraght ne abbiamo una lapalissiana conferma. Il villaggetto a uso dei surfisti non esiste più, la spianata è fresca, dietro di noi i bulldozer vanno avanti fino a notte. All’ingresso del cantiere campeggia un favoloso rendering di quello che sarà: un luccicante piazzale lastricato, tra la riva e la provinciale che porta ad Agadir. Nel centro, unico elemento decorativo, una scultura si eleverà verso il cielo della modernizzazione in un Marocco finalmente competitivo: un’imponente, marmorea tavola da surf.


Da L’Almanacco de La Terra Trema. Vini, cibi, cultura materiale n. 33
20 pagine | 24x34cm | Carta cyclus offset riciclata gr 100
Per ricevere e sostenere questa pubblicazione: info@laterratrema.org
Last modified: 18 Ago 2024